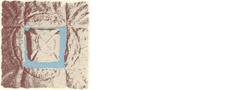Intervista alla Dott.ssa Alessandra Razzano, psicologa psicoterapeuta presso il Centro di Fisiopatologia della Riproduzione e PMA del Presidio Ospedaliero Sant’Anna – SSD PSICOLOGIA CLINICA – Città della Salute e delle Scienze di Torino.
A cura di Giuliana Bitelli
Torino, 12.11.2024
Grazie di essere qui Alessandra, con la tua esperienza pluriennale nel settore dell’infertilità e della fecondazione assistita, e di aver accettato di dedicare del tempo a me e all’associazione della SPT che si arricchirà di queste esperienze condivise. E’ molto bello poterti ascoltare nella tua esperienza lavorativa su un tema così ancora inesplorato, specifico e delicato nella vita delle persone, donne e coppie, così centrale per l’umanità intera.
Il tuo articolo mi ha interessata molto per i molti aspetti toccati, e vorrei iniziare da un aspetto che ha particolarmente richiamato la mia attenzione: l’intreccio mente-corpo, inconscio-organico è intenso e misterioso, e credo che l’inconscio possa ogni tanto remare contro al corpo e alle sue esigenze e richieste; è molto bello per noi analisti del profondo poter dire che l’inconscio gioca un ruolo importante anche sul corpo, bloccandolo o mettendolo contro i desideri, ma facciamo attenzione al rischio di dare alla infertilità, magari misteriosa perché impossibile da spiegare a livello scientifico, una spiegazione generalizzata di blocco psicologico; ci sono infatti coppie fisicamente infertili capaci di dare corso al loro desiderio procreativo e in grado di realizzare una fertilità “di cuore”, un’apertura mentale ed emotiva che potrà poi eventualmente tradursi in una capacità generativa anche fisica.
Per noi è molto interessante questo ambito del mistero della infertilità: in passato alcune tesiste avevano sviluppato uno studio sullo stile di attaccamento delle coppie con diagnosi di infertilità sine causa. Abbiamo visto che molte di esse portavano dentro di sé traumi irrisolti nella loro storia di vita, però ci siamo resi conto che i traumi irrisolti non possono essere necessariamente all’origine o influenzanti l’infertilità. Sarebbe come dire che queste coppie sono responsabili della loro infertilità perché hanno traumi irrisolti; ma quante persone hanno traumi irrisolti senza essere sterili? Quindi mettersi in questo orientamento diventa un po’ pericoloso e anche stigmatizzante per le coppie.
C’è tutto un grosso discorso circa il rapporto di identificazione figlia-madre che incide tantissimo sulla capacità procreativa, lo rilevi?
Può essere. Ho in mente alcune pazienti vittime di deprivazione affettiva da parte delle loro madri con fragilità emotive: continuamente maltrattate, è frequente che queste donne non vogliano figli perché terrorizzate di diventare come le proprie madri. Quindi capita che neghino completamente la loro parte materna; poi tutto d’un tratto, magari inaspettatamente, si trovano a svolgere un ruolo di cura sul piano professionale, e a quel punto scoprono che ne sono capaci: si attiva una parte materna ancora sconosciuta e allora provano a realizzare il loro nuovo desiderio. Una donna con una storia simile aveva poi sperimentano fin da subito concepimenti falliti e aborti spontanei, fino alla proposta, da parte delle équipe mediche, di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo. A questo punto lei stessa si era interrogata se non portasse avanti le gravidanze perché dentro di sé questa “madre negativa” in qualche modo agisse ostacolandola; si chiedeva se forse era proprio la paura di ripetere la realtà psichica di sua madre e agirla su un figlio a ostacolare i processi naturali di impianto di un embrione.
Potremmo dirci che l’esperienza di un materno “abusante” non aiuta a portare avanti le gravidanze? Porsi questi interrogativi è utile ma è ancora più utile non rispondere e fermarci alle ipotesi sulle varie possibilità.
Quindi possiamo dire che la complessità è tale che non possiamo spiegare tutto; c’è un profondo intreccio tra mente e corpo, ma quali siano poi i meccanismi intimi reali non è dato sapere con precisione.
Ecco concordo, non possiamo connotare queste situazioni con causa-effetto. Il resto dell’articolo mi è piaciuto moltissimo, ho trovato molto bello la parte in cui tu parli di assenza e inesistenza; molto bello l’aspetto della reale esistenza di questi bambini; è vero che li si vuole ritrovare presenti nel corpo ma è anche vero che molto spesso questi bambini non sono stati davvero concepiti nella mente e quindi restano inesistenti, nel senso di non pensati, come viceversa a volte sono stati molto pensati, ma effettivamente sono mancanti nel corpo materno. A questo proposito ti segnalo che la mia collega e io abbiamo scritto un libro, dal titolo Il viaggio di Dedè, che chiudiamo con il senso del concepimento: il vero concepimento è quello “nel cuore”: quello che conta è nascere nel cuore, al di là di venire al mondo con il trattamento omologo o eterologo. Si parla del grande impegno che si richiede ai genitori per arrivare fino lì.
Nell’articolo ho puntato l’attenzione sul materno creativo e sul maternage, ma è chiaro che c’è sempre la coppia che lavora per creare spazio di accoglienza e superamento del proprio limite procreativo naturale.
Rispetto invece alla questione, a cui accenni, del “figlio a tutti i costi” portato avanti dalla donna e dalla coppia, mi pare che oggi sia un po’ cambiato l’atteggiamento generale. All’interno di un Presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale che segue le Linee guida regionali in materia a norma della PMA, i tentativi di procreazione assistita sono limitati; ciò che osservo è che le coppie sono consapevoli e non vogliono diventare ostinate, chiudersi soltanto in quel progetto che diventa poi esclusivo, non vogliono fare diventare questa pratica una compulsione. C’è una maggiore consapevolezza dei rischi dell’accanimento. Hai ragione quando dici che c’è la possibilità di essere creativi comunque, a prescindere dalla possibilità di avere un figlio; questo aspetto si sta interiorizzando. È stato realizzato un progetto molto interessante e innovativo per le scuole, Progetto FERTIL-MINDS, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di Torino, su come i ragazzi e le ragazze del liceo vivano il problema della fertilità, e abbiamo notato che molti di loro mettono già in conto di poter non avere figli o non volerli; molti di loro sanno che la loro realizzazione personale non passerà necessariamente dalla scelta di avere figli. Solo dieci anni fa la fertilità era data come un bene ovvio, mentre invece oggi c’è molta capacità di riflessione su questo tema e questa convinzione non è più così scontata. Un altro grande tema per le coppie infertili che si rivolgono alla PMA è quello del ‘salvatore-donatore’, presente nel libro-guida: il paragone fra i due archetipi offre la possibilità di far sedimentare e radicare nella mente collettiva immagini nuove rispetto alla donazione di materiale genetico, che le permettono di renderla più accettabile. Come la donazione di organi permette i trapianti, così la donazione di gameti permette una procreatività sempre più accessibile. Donare organi generativi è diventata una strada percorribile. La crisi di rigetto ci può essere in entrambi i casi: come si prepara un corpo ad accogliere un nuovo organo così è necessario preparare il corpo e anche la mente ad accogliere qualcosa di generativo che fisicamente non ci appartiene e che viene da lontano e magari non si sa da dove.
È interessante offrire alle coppie la possibilità di lavorare sulla donazione e sulle fantasie che le coppie hanno sui donatori: spesso vediamo ad esempio che i soggetti coinvolti nei percorsi psicologici, quando devono dire come si rappresentano il donatore o la donatrice, lo dipingono somigliante a loro stessi come per colmare il gap tra loro portatori di incapacità procreativa e il donatore con capacità fecondante. Grazie a questi giochi di immaginazioni rappresentative, emergono anche atteggiamenti di patteggiamento con la donatrice o il donatore: dalla ‘competizione’ si può scoprire una ‘alleanza’ e arrivare a considerare la donazione proprio come un dono arricchente, e non più la conferma delle propria incapacità. Allora è anche importante considerare questa dinamica come uno “scambio” in cui alla retribuzione corrisponde l’ottenimento di quel materiale prezioso. Ognuno trova il suo “tornaconto”: per le donatrici ad esempio potrebbe diventare importante l’aspetto altruistico, molto presente in questo gesto donativo, se pensiamo alla complessità dell’operazione che comprende cure ormonali, prelievi ovocitari e la messa in gioco del loro corpo: tutto ciò avviene molto prima dell’atto finale del donare l’ovocita da fecondare. Avevo seguito tanti anni fa una donna che era nella condizione di ricevere un ovocita da una donna più giovane: all’inizio era molto in competizione perché la donatrice era giovane e fertile; alla fine era andata in chiesa ad accendere un cero come segno di gratitudine verso di lei: aveva infatti capito che era più sano entrare in una relazione pacificata. La ferita narcisistica resta, e, se non ci si lavora, crea senso di inferiorità, rabbia, dipendenza, anche depressione. La pacificazione con il proprio limite è necessaria anche in vista dei figli che verranno e a cui si dovrà spiegare con chiarezza la loro origine. È importantissimo avere chiaro che la tecnica non andrà a sanare quella ferita, perché quella ferita resterà: la tecnica non cura il corpo “malato” se ci pensiamo bene, altrimenti dopo si dovrebbe essere in grado di procreare da soli. La tecnica risponde al “bisogno” di un figlio, ma il corpo rimane infertile e anche per un secondo eventuale figlio quella coppia e quella donna dovranno ripassare dalla tecnica, anche se non è infrequente che dopo un primo intervento tecnologico la coppia riesca poi a concepire naturalmente. Il figlio resta per sempre nato in quel modo, cioè resta sempre figlio della tecnica, ma la serenità e l’accettazione dei genitori non ne farà uno stigma ma piuttosto una caratteristica specifica e una risorsa, effetti di un dono.
Stiamo dunque dicendo che è chiaro e importante che la coppia o la donna accettino la nascita tecnologica e ancora prima la ferita narcisistica dell’incapacità procreativa del proprio materiale generativo. Questo aspetto più organico non è detto si possa curare ma è necessario si debba accettare e trasformare. Grazie Alessandra per queste precisazioni.
La scoperta dell’infertilità è un trauma vero e proprio, anche con dei trigger continui, da intendersi come stimoli -immagini, odori, luoghi- che richiamano una precedente esperienza traumatica senza essere necessariamente spaventosi o sensazionali ma semplicemente di richiamo indiretto o superficiale del trauma. Ad esempio il ciclo mensile è un trigger, la vita con il figlio che è nato così è un altro trigger. Sono richiami che riportano al trauma di scoperta dell’”imperfezione” che dev’essere proprio rielaborato, digerito, a prescindere dall’esito del trattamento. Circa la riuscita dell’elaborazione, tanto incide la propria storia individuale, l’esperienza di vita, il proprio rapporto con le figure genitoriali, in special modo con la propria madre, il rapporto di coppia, le risorse della futura coppia genitoriale. È importante poi che il processo di rielaborazione della ferita narcisistica sia di coppia, a prescindere da chi dei due porta il problema di infertilità: non può essere un problema di colpa dell’uno o dell’altra ma è una situazione della coppia nel suo insieme, nella sua unità. A volte l’esperienza dell’infertilità restituisce alle coppie che accettano di fare un percorso di presa di coscienza della propria condizione un nuovo modo di stare insieme, molto prezioso perché sentono di essersi scoperti come coppia, di avere fatto passi avanti, di non essersi impoveriti. Tuttavia, nonostante ci sia l’opportunità di intraprendere percorsi di trasformazione della propria ferita di base sulla capacità procreativa, non credo che l’eterologa in particolare sia una pratica per tutti. È un percorso peculiare che ha bisogno di una preparazione. Non è così scontato riuscire ad accettarla. Le coppie devono fare, oltre al lavoro di accettazione del proprio limite, anche quello di “accoglienza del diverso”. In un convegno organizzato sul tema, una coppia ha portato la propria testimonianza di procreazione medicalmente assistita con materiale eterologo. Ha raccontato che dopo molti tentativi con materiale omologo, falliti tutti, è stato detto loro che non potevano più continuare con quella modalità e che avrebbero dovuto passare all’eterologa; la comunicazione secca e senza preamboli ha creato in loro una rabbia enorme e un’aggressività che li ha inizialmente allontanati dal progetto procreativo. È stato necessario tutto un lungo lavoro di elaborazione dei loro vissuti e delle loro esperienze precedenti per poter poi avvicinarsi a un altro percorso. I partner della coppia hanno vissuto l’anno di elaborazione psicologica delle loro emozioni come un anno “importantissimo” della loro vita: ha permesso loro di sentirsi di nuovo vivi, vitali e fecondi; hanno infatti realizzato la fecondazione eterologa e la neo-mamma ha iniziato una gravidanza. I partner si sono resi conto di quanto fossero non disponibili ad accettare un percorso eterologo subito dopo aver avuto la delusione dei tentativi omologhi; ci è voluto un anno per una trasformazione profonda che permettesse l’accoglienza di materiale estraneo alla coppia. Dopo che la coppia ha riscoperto il desiderio, quel percorso è diventato molto semplice, nonostante la sua complessità. La riscoperta del desiderio e la potenzialità creativa arrivano ad aprire le porte a un figlio, in qualunque modo concepito.
Rispetto al parto e all’allattamento ci sono differenze e specificità?
Molte donne PMA sono ben orientate al compito e all’obiettivo di avere un figlio e dedicargli corpo, mente e cuore, durante la gravidanza e dopo. Le immaginazioni di queste mamme sul parto non sono dissimili dalle madri con concepimento naturale: sono spesso desideri di parti naturali; quando le cose cambiano restano deluse da loro stesse, come se non fossero state abbastanza capaci di fare le madri partorienti secondo natura, e così anche per l’allattamento. In specifico, le neo-madri PMA sono spesso tradite dalla realtà fisiologica ossia da complicanze previste dalla pratica di procreazione assistita; nonostante questa previsione, hanno un vissuto di fallimento, come se l’essere una buona mamma durante la gravidanza e dopo valesse come riparazione della loro incapacità procreativa, e quindi il fallimento delle loro buone pratiche materne, gestite con naturalezza dalle altre mamme, le colma di sofferenza e delusione di sé. Una riflessione sulla “capacità”: la capacità è l’unità di misura che noi utilizziamo per dire quanto un contenitore contiene; il vaso capace è quello che può riempirsi, il vuoto è la ricchezza del vaso ossia è la sua capacità di svolgere il proprio compito di accogliere oggetti e materiali da custodire. Il seno è un contenitore di latte, l’utero è un contenitore di bambini, entrambi capaci in una certa misura. Se una donna si sente incapace di concepire si sente anche incapace di allattare, e persino di crescere il figlio tanto desiderato.
Sembra che il non essere in grado possa coincidere con la percezione di avere contenitori senza vuoto?
Purtroppo è così. Per le donne c’è una transizione tra l’essersi sempre immaginate fertili e doversi poi scontrare con una nuova immagine di sé fallace, ri-immaginarsi fertili, anche se poi di fatto nel corpo non lo sono e non lo diventeranno, ma è importante che restino fertili nella mente cosicché quando poi il corpo sarà pronto alla procreazione saranno pronte ad accogliere la gravidanza, oppure quando il corpo non sarà purtroppo in grado di essere fertile neppure grazie alla tecnica resterà quella fertilità psichica che porterà la donna e la coppia oltre, in un terreno di riscoperta e comunque auspicabilmente di arricchimento.
Sui nuovi bimbi nati da PMA ci sono già studi e osservazioni?
Gli studi fatti sui bambini figli di PMA riportano che molto spesso essi raggiungono le tappe evolutive prima degli altri bambini. E quindi questi bambini parlano prima degli altri, camminano prima degli altri, e questo va a confermare i genitori sulla loro validità/capacità genitoriale.
È curiosa questa notizia: sarà la risposta inconscia dei bambini stessi che “com-prendono” l’aspettativa dei genitori e vanno in risonanza con essa rispondendo adeguatamente per salvarli dal dubbio di “capacità”, nonostante abbiano riempito utero e seni della madre?
È del tutto possibile, si dovrà studiare ancora il fenomeno.
Anche il tema della “delega” è importante in questo complesso sistema di lutto, nascita e genitorialità: c’è una delega per l’analisi della capacità procreativa e per la fecondazione, una delega per il parto che spesso è cesareo, una delega per l’allattamento. C’è una serie di studi sulla correlazione PMA-TC (taglio cesareo): molte donne preferiscono, o per scelta personale o su suggerimento del medico che poi accettano, partorire con taglio cesareo: sentono che delegare al medico il loro parto sia più rassicurante rispetto al parto spontaneo; la donna spesso vive il parto spontaneo come più rischioso per quel dono prezioso ricevuto che può “rompersi”, rovinarsi, guastarsi, andare perduto dopo tanta fatica. Bisogna anche considerare che le donne che si sono sottoposte a interventi ripetuti, a rischi continui, a sfide e insuccessi e che poi riescono ad avere finalmente il loro utero ben “capace”, sono stanche, sono sfibrate da una lunga sofferenza iniziata molto prima della PMA e non ancora finita al momento della nascita. Quindi quando si è stanchi e sofferenti, chiedere aiuto e delegare è anche sano. Ogni situazione va quindi conosciuta nel particolare, e questa disciplina non può essere generalizzabile.
Un altro aspetto nuovo e di ampia prospettiva è quello del “lavoro con gli operatori”; hai scritto molto bene della proiezione e identificazione proiettiva delle donne-coppie e degli operatori medici e biologi circa l’onnipotenza del medico, con gli effetti deleteri della delusione quando il medico viene meno al mandato del dare un figlio. Per questo sarebbe importante fare un lavoro informativo, e non solo, sugli aspetti psicologici dell’infertilità proprio con gli scienziati che se ne occupano sul piano organico, anche per alleggerirli e tutelarli da un ruolo che non dovrebbero avere.
C’è un bisogno inconscio di onnipotenza sulla manipolazione della natura che le équipe mediche praticano svolgendo il loro impegno con la PMA?
È possibile, sarebbe interessante studiarlo.
Interessante anche per noi psicoterapeuti non specializzati come te sapere ciò che mi hai trasmesso e cioè che questo percorso non è per tutti: forse la tecnica dice che è possibile perché si tratta di un gesto medico e tecnologico, ma è la parte psichica che reclama un suo spazio e un suo diritto di attenzione e trattamento di coscientizzazione. Fare spazio a un livello non fisico: è questo dunque il problema e la sfida. Si tratta infatti di uno spazio da costruire e da elaborare, non è scontato che esista solo perché c’è una équipe medica specializzata che sa fare il suo mestiere. Un bambino non può essere concepito solo a livello fisico, dicevi, e quindi dire che il percorso non è per tutti non è certo una discriminazione a priori, ma presuppone un’attenta valutazione da parte del tuo lavoro specializzato che permetta alle coppie di capire quando, e se, essere disponibili a un’esperienza che non ha ancora modelli interiorizzati, ancora troppo pochi per potercisi identificare, per avere dentro una guida e una via.
Il lavoro, prima ancora del mio, è il tuo, è quello di tutti gli psicologi che a monte aiutano le persone a rendersi conto dei loro limiti e delle loro risorse, e che orientano l’accesso ai servizi per la procreazione assistita. È stato fortemente voluto da me e dalle mie colleghe un progetto di accoglienza, orientamento e informazione per le coppie che cercano PMA: il progetto riguarda l’accesso al servizio e comprende un colloquio orientativo psico educativo, in cui sono sempre presenti una psicologa, un’ostetrica, un infermiere, un biologo medico, un medico; è un incontro collettivo per cui le coppie si riconoscono simili in mezzo ad altre e iniziano fin da subito a ridurre lo stigma osservandosi vicendevolmente; è molto bello offrire le informazioni principali da parte del ventaglio dei professionisti; in genere le coppie che accedono al servizio hanno un anno di attesa, e quindi in quel tempo iniziano a fare gli incontri previsti dal progetto in cui ricevono non solo le prime informazioni ma anche i primi suggerimenti di letture per iniziare a valutare e a conoscere; possono fare tutte le loro domande e noi spieghiamo tutta la parte psicologica rispetto alle risorse di coppia, alle fatiche e a quali saranno i momenti potenzialmente più complessi, cosa possono fare e non fare, a chi si possono rivolgere. Inoltre regaliamo un libro scritto da noi con tutti i vari passaggi; al fondo del libricino trovano uno spazio vuoto con domande aperte a cui, se vogliono, possono rispondere come se fosse un diario di bordo. Trovo che sia molto bello perché le coppie arrivano al P.O. Sant’Anna di Torino con una domanda medica e non psicologica; è dunque importante proporre di partire proprio dal lato psicologico o comunque offrirlo fin da subito nella presentazione del Centro. Partire dall’informazione generale includendo l’aspetto psicologico permette loro di far nascere la domanda per un’elaborazione emotiva: abbiamo visto che la sola domanda organica non porta buoni frutti, è uno spreco di tempo, energie e risorse per tutti. È bello vedere come le persone si riconoscano appena iniziamo a enunciare quali possono essere i vissuti, le fatiche della coppia, e se parli dell’uomo è frequente che la compagna metta una mano sulla gamba del marito, se si parla di lei è il marito a mettere un braccio intorno al collo della compagna.
Allora il “non per tutti” è qualcosa che lo psicologo clinico può avere nella sua mente e che lo orienta su un percorso che faciliti la coppia all’apertura, all’accoglienza e a una nuova fertilità su altri piani. Succede spesso di dover comunicare alla coppia che non è percorso adatto a lei?
Avviene e per fortuna possiamo segnalarlo; vengono fuori infatti molte e complesse dinamiche di coppia: ad esempio la sessualità non serve più per procreare e allora diventa vuota di piacere, una sessualità che è stata martoriata; questi interventi sono sempre lì nell’intimità, una intimità svelata.
Dinamiche complessissime e nuove! Voi siete dei pionieri della psicologia della nascita assistita, come saranno pionieri i colleghi psicologi dell’infanzia che vedranno i bambini figli di PMA. Nelle classi si trovano già bambini figli di donazione di seme e di ovocita; questi bambini portano il problema della mancanza-assenza: i donatori di organi procreativi sono assenti? Mancanti? Presenti? I bambini possono, e devono, conoscere le loro origini dai genitori stessi che, attraverso un linguaggio adatto al loro bambino, con chiarezza e semplicità raccontano cosa è successo alla loro mamma e al loro papà e a loro stessi; il “segreto” delle origini è importante sia svelato mentre il “mistero” della nascita di ogni figlio mantenuto, nella consapevolezza che i figli non si possono conoscere davvero fino in fondo. Certo è necessario usare i termini giusti, dare i nomi giusti agli attori di tutta la scena complessa, in modo che i bambini comprendano che il donatore ha un ruolo e una funzione preziosa per la loro nascita; poi c’è il ruolo del medico, il ruolo delle altre figure professionali intervenute. Queste figure restano costanti dentro la mente dei bambini e nell’esperienza complessa dei genitori.
… come fantasmi? Come agenti attivi? O al peggio come passivi e in ombra?
C’è una presenza che è stata significata o al peggio secretata, ma sempre la presenza è fantasmatizzata; per questo alcuni stati permettono al figlio di conoscere la sua origine e i soggetti che insieme a padre e madre gli hanno dato la vita. Per associazione posso dirti che una paziente adottata mi ha riferito di associare il nome Mamma solo alla madre che l’ha cresciuta e non alla madre “biologica” che l’ha concepita, ma con cui non ha coltivato affetto e legame. Per lei era stato liberatorio non dare un nome alternativo (che in realtà non c’è) ma quello di battesimo.
Sembra dunque che il nome giusto dà il senso al legame, la definizione giusta. La psiche si adatta plasticamente ai temi creati dalla cultura.
Sono d’accordo.
Cara Alessandra ti ringrazio di tutto, è stato molto interessante e ricco. Grazie del tuo contributo per noi psicoterapeuti della SPT che potremo proporre la terapia della sabbia in modo ora più oculato e responsabile.
Bibliografia
Delia C., Razzano A. (2023), Il viaggio di Dedè, Torino, Voglino Editore